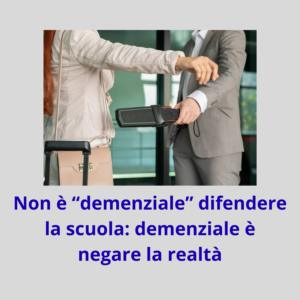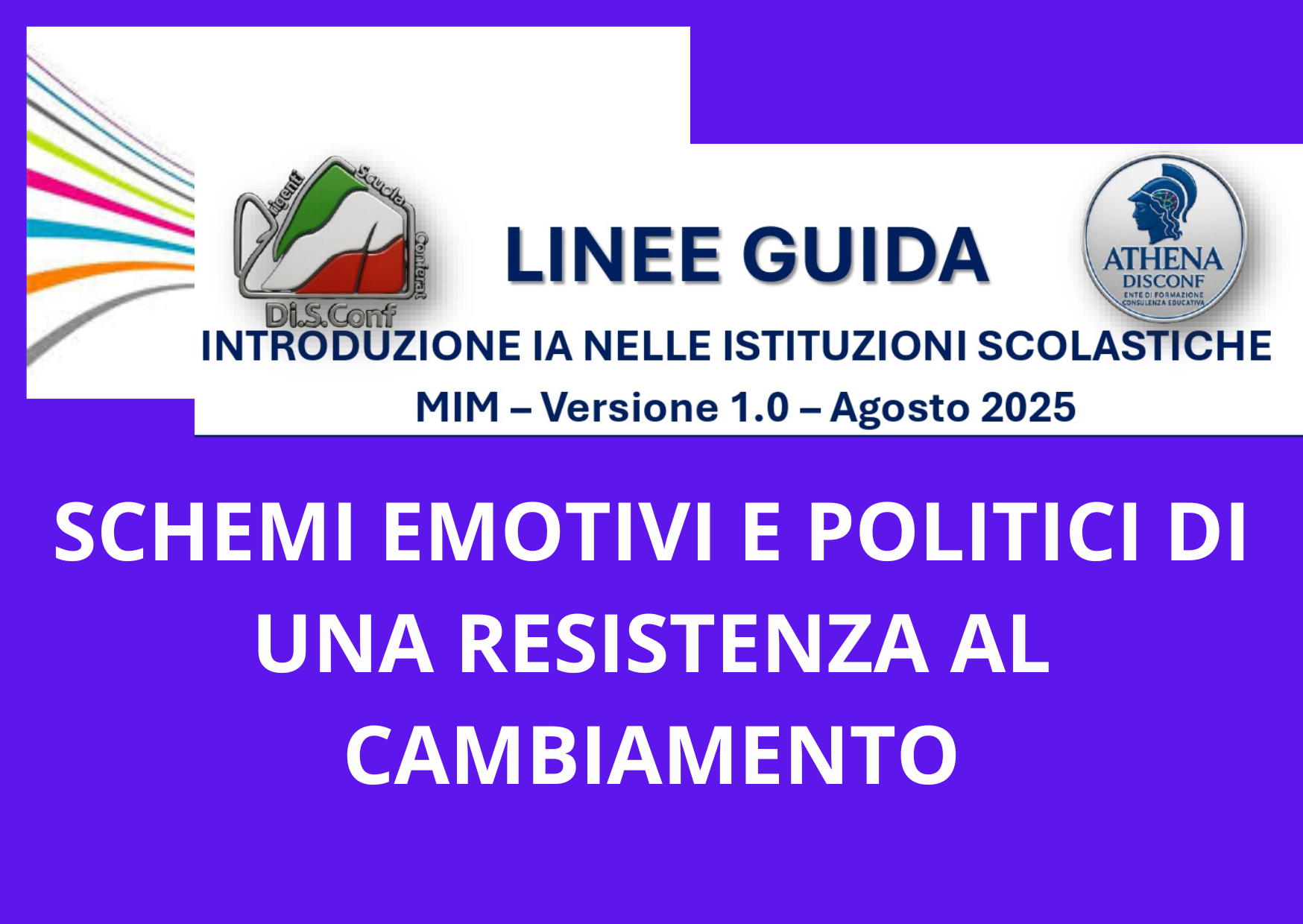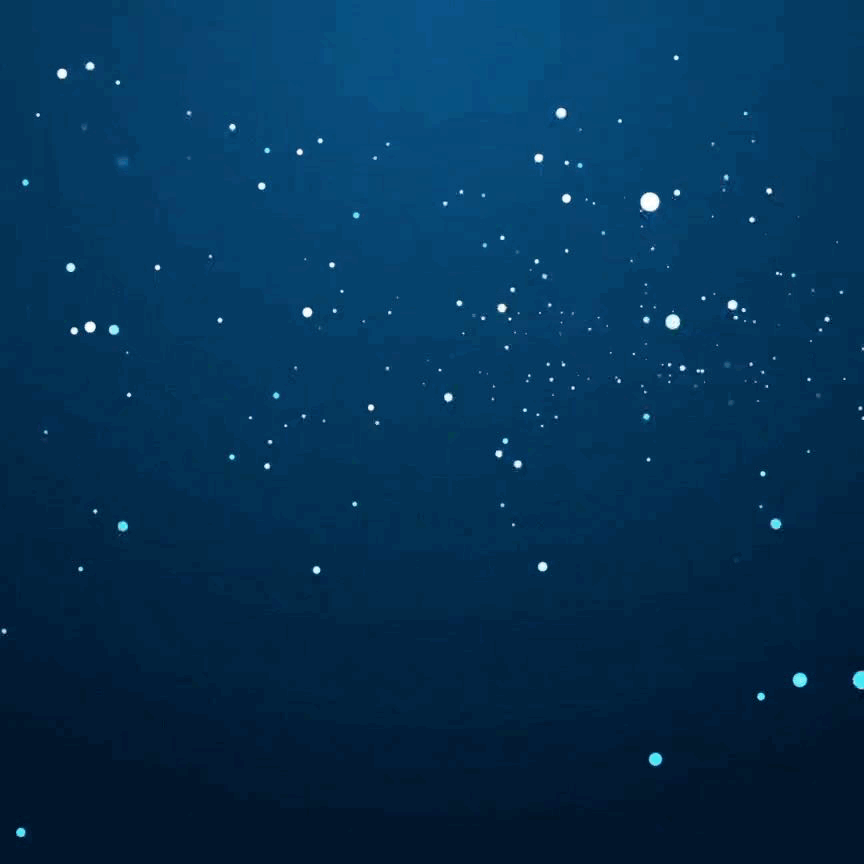L’articolo che segue, redatto dall’ Ufficio Stampa DIRIGENTISCUOLA e già pubblicato su un quotidiano nazionale, propone una riflessione critica sulle recenti linee guida del MIM in materia di intelligenza artificiale nella scuola.
Si pone l’accento su un aspetto in particolare, che solleva alcune perplessità: l’impressione è che il Ministero cerchi di governare un cambiamento già ampiamente avvenuto. Quasi bastasse un “bugiardino” di una manciata di pagine per tenere a freno uno tsunami che si sta abbattendo sul nostro modo non solo di apprendere, ma di pensare, lavorare e vivere.
L’intento dell’articolo non è quello di concludere il dibattito, ma di stimolare un confronto aperto e consapevole, su come (e se) la scuola possa davvero governare un fenomeno tanto rapido quanto profondo come l’IA, alla luce della visione “antropocentrica” richiamata più volte dallo stesso MIM nel documento.
01 Settembre 2025 alle 15:26
” In una valle verdeggiante vivevano una Quercia imponente e un piccolo Ruscello che scorreva ai suoi piedi. La Quercia era fiera della sua altezza e forza. Guardava il Ruscello con sufficienza: “Tu sei solo un filo d’acqua”, gli disse. “Io invece svetto in cielo e do ombra. Tu scorri senza sosta, sempre piegato, non hai forza né fermezza”. Il Ruscello non si offese: “È vero – rispose – ma quando incontro un ostacolo lo aggiro. Quando arriva la tempesta scorro più veloce. Tu invece resti ferma, rigida”. La Quercia sbuffò: “Io non ho bisogno di fuggire. Le tempeste non mi spaventano!”.
Pochi giorni dopo scoppiò un temporale. Il cielo si fece scuro e il vento ululava. Il Ruscello si gonfiò e continuò a scorrere, adattandosi al nuovo corso. La Quercia invece, dritta e orgogliosa, oppose resistenza. Ma il terreno divenne molle e le radici cedettero. Con un tremendo schianto la grande Quercia cadde. Quando tornò il sole, il Ruscello mormorò: “La forza che non si piega finisce per spezzarsi”.
La favola non è di Esopo, Fedro o La Fontaine: è frutto di una banale istruzione fornita all’Intelligenza artificiale, che se ne è uscita con un “remake” della nota storiella – questa sì di antica tradizione – della Quercia e delle Canne. La morale, però, è sempre valida: inutile cercare di imbrigliare ciò che non si può governare. Soprattutto quando la tempesta si sta già scatenando sopra di noi.
Allegorie favolistiche a parte, è proprio sull’Ia che vogliamo tornare, alla luce delle “antropocentriche” Linee Guida ministeriali licenziate lo scorso 29 agosto. Diciamo subito che ci sembra corretto che un Ministro dell’Istruzione si dimostri sensibile ai rapidi cambiamenti che stanno interessando anche le nostre scuole, intese sia come diramazioni territoriali della Pa, sia (soprattutto) come contesti di apprendimento, educazione e formazione. Ciò che non condividiamo, semmai, è il metodo, da “prove tecniche di resistenza al cambiamento”.
Innanzitutto una doverosa premessa, sempre metodologica: ancora una volta assistiamo al perpetuarsi della malaprassi secondo cui il Ministero, a fronte di una novità rilevante, omette di darne informativa preventiva ai sindacati, che ne vengono puntualmente a conoscenza da fonti non ufficiali quando ormai i giochi sono fatti. Un modus operandi che, fosse solo per questioni di etichetta, non può essere condiviso.
Entrando nel merito, colpisce l’intempestività dell’intervento, che fra l’altro giunge proprio nei giorni in cui scatta anche per le scuole superiori il divieto di utilizzo degli smartphone, che dell’Ia sono tra i principali strumenti e vettori.
Senza voler scomodare pionieri come Alan Turing, McCarthy, Rochester, Shannon o, in tempi più recenti, Marvin Minsky (la sua “Società della mente” risale al 1985), di infosfera, quarta rivoluzione, Ia generativa si parla almeno da un ventennio, così come delle questioni etiche che il suo avvento comporta: già nel 2007 il Rapporto Legg-Hutter individuava ben 53 definizioni di intelligenza, ciascuna delle quali potenzialmente “artificiale”, e 18 definizioni di IA.
A ricordarcelo è Luciano Floridi, sociologo della comunicazione che tre anni fa ha dedicato un intero saggio proprio all’etica dell’Ia, dimostrando come si tratti di una “nuova forma dell’agire”, capace di re-ontologizzare e re-epistemologizzare la modernità ridisegnandola. Termini che non possono lasciare indifferente chi opera con consapevolezza nel mondo dell’istruzione e formazione.
Ora: davvero crediamo che una tale svolta antropologica e culturale, paragonabile all’introduzione della stampa, del motore, dell’elettricità, del telefono o della tv possa essere “strutturata, organizzata e governata” nelle nostre scuole (Linee guida cit., Premessa pag. 3) a partire da un documento di principio che cuce insieme generiche riflessioni etiche e improbabili suggerimenti operativi? Siamo realmente convinti che, nel 2025, si possa attuare una “strategia” per l’introduzione dell’Ia a scuola (p. 7), e sia possibile “spiegare e comprendere i processi decisionali dei sistemi di Ia” (p. 9), o comprendere se i nostri dati siano utilizzati per l’addestramento dell’Ia autoapprenditiva (p. 11) in un mondo in cui si dibatte perfino – senza risposte univoche – sul come l’Ia sia capace di raffinare il proprio apprendimento istante dopo istante?
L’impressione è che il Ministero cerchi, donchisciottescamente, di governare un cambiamento già ampiamente avvenuto almeno in direzione bottom-up, a partire dall’utenza stessa della scuola. Del resto i numeri dimostrano che, a scuole chiuse, l’utilizzo dell’Ia crolla drasticamente. L’ultimo report Open Router è impietoso: mentre i giorni finali dell’anno scolastico sono stati quelli del picco massimo di traffico Ia, con la chiusura delle scuole il calo è stato netto. E così avviene anche durante weekend e festività. Fatto due più due, ciò significa che ChatGpt e consorelle, con buona pace di ogni Linea guida, sono ormai “fornitori ufficiali” di compiti – a casa o in classe – e crediamo anche di lezioni preparate per molti docenti.
Così, al di là delle buone intenzioni, non può lasciare indifferente il lettore attento (e il dirigente scolastico informato) lo scarso respiro di questo documento, che in ultima analisi pare volto a ridurre a una dimensione controllata e “antropocentrica” quella che appare, a ogni effetto, come una rivoluzione antropologica senza ritorno. Quasi bastasse un “bugiardino” di una manciata di pagine per tenere a freno uno tsunami che si sta già abbattendo, e non da ieri, sul nostro modo non solo di apprendere, ma di pensare, lavorare e vivere. Caro Ministro, osavamo sperare in qualcosa di più”